Italia: Una. Campanili: più di 8 mila. Punti di vista: milioni.
C’è ancora molto da lavorare.
Iniziamo a riconoscerci tutti nella Costituzione: leggendola, promuovendola e – soprattutto – rispettandola.
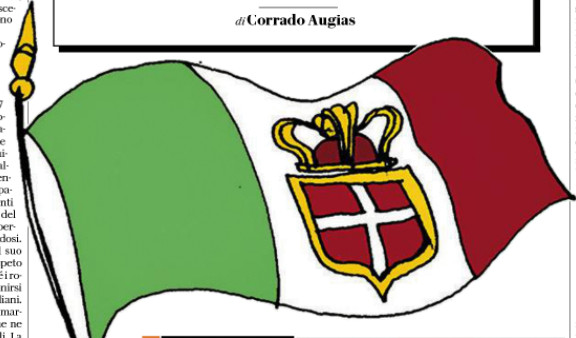
La seconda strofa dell’Inno nazionale, quella che pochi conoscono e nessuno canta, dice così: «Noi fummo da secoli calpesti, derisi/perché non siam popolo,/ perché siam divisi».
Amara constatazione dopo la quale viene un auspicio: «Raccolgaci un’unica Bandiera, una speme: di fonderci insieme». Quando il ventenne poeta genovese Goffredo Mameli scrisse quei versetti, la “fusione” era ancora lontana. Quel giovane di gran cuore era corso a Roma a difendere l’effimera e gloriosa repubblica romana del 1849 e lì cadde, a 21 anni, colpito dal piombo dei francesi scesi a sorreggere il vacillante trono di papa Pio IX.
Poche righe e già trapela il groviglio di soggetti, interessi, conflitti, nonostante i quali la nostra faticosa unità riuscì finalmente ad essere proclamata e sancita dalla legge n. 4671 del 17 marzo 1861. Mancava ancora Roma; bisognava piegare l’ostinazione fuori tempo del papa che intendeva mantenere quel dominio alla Chiesa. A nulla erano valse le caute, ragionate, convincenti lettere del conte di Cavour. Il papa, terrorizzato dai cambiamenti portati dall’imminente arrivo del nuovo secolo (il socialismo, la libertà di stampa), reagiva arroccandosi. Ci volle la disfatta a Sedan del suo protettore Napoleone III, l’impeto dei bersaglieri a Porta Pia perché i romani potessero finalmente riunirsi (20 settembre 1870) agli altri italiani.
Sono passati 160 anni da quel marzo 1861, possiamo chiederci che ne sia stato dell’auspicio di Mameli. La bandiera e la speme hanno “fuso” gli italiani? O no?
Non in questo momento, si direbbe. Un anno di pandemia ha accresciuto le divisioni: nord e sud, vecchi e giovani, nuclei agiati e altri in penuria, studenti che imparano mentre altri no, commerci consentiti e commerci preclusi, sani e malati, vivi e morti, una spaventosa quantità di morti — più di centomila ormai.
Compiamo una magia, quantomeno immaginiamola. Supponiamo che il flagello della pandemia di colpo scompaia. Quale sarebbe la situazione? Mi avvalgo per rispondere dei dati pubblicati dalla Fondazione Edison diretta da Marco Fortis (insegna Economia industriale alla Cattolica a Milano) in un compendio statistico pubblicato in occasione del suo ventennale (2019). I dati, in sintesi, sono questi: «L’Italia vanta la seconda manifattura e la prima agricoltura d’Europa, il quinto miglior saldo commerciale manifatturiero con l’estero a livello mondiale, il secondo più alto numero di pernottamenti di turisti stranieri tra i Paesi dell’Euroarea, una ricchezza finanziaria netta delle famiglie che è due volte più grande del Pil, un surplus primario cumulato dello Stato che dal 1995 al 2018 ha superato i 700 miliardi di euro».
Cifre che ovviamente precedono l’arrivo del Covid, però segnalano una tendenza che, è ragionevole credere, tornerà, magari un po’ indebolita, quando la pandemia sarà sconfitta. Nel Compendio della fondazione leggo anche: negli ultimi anni il Pil pro capite italiano è cresciuto ad un tasso maggiore di quello dei paesi del G7. Il consumo pro capite delle famiglie è aumentato più rapidamente rispetto a molti altri paesi dell’Ue, tra cui Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Austria, Belgio e Finlandia. L’Italia ha il quinto maggior surplus commerciale al mondo per i prodotti manifatturieri. È leader o co-leader a livello globale per centinaia di manufatti.
Devo credere a queste cifre, anche se vedo quanto nettamente contrastino con una certa tendenza generale (stampa compresa) all’autocommiserazione. Una vecchia piaga cui ha accennato anche il presidente del Consiglio Mario Draghi nel discorso d’insediamento: siamo i primi denigratori di noi stessi, dovremmo avere un po’ più d’orgoglio, ha detto. Invece l’orgoglio manca; intendo la consapevolezza d’appartenere a una nazione che ha dato al mondo in termini di avanzamento, progresso, qualità, bellezza, più di quanto dal mondo abbia ricevuto.
Ma poiché parliamo di unità nazionale, per restare aderenti alla realtà si deve citare anche l’enorme divario tra il nord e il sud del paese. Vittorio Daniele (ordinario di Politica economica a Catanzaro) ha pubblicato un saggio dal titolo Il paese diviso ovvero Nord e Sud nella Storia d’Italia ,(Rubbettino, 2019). Per una quantità di ragioni storiche, sociali, geografiche, la diversità di sviluppo tra il Mezzogiorno e il resto d’Italia oltre a essere ampio, è cronico: rappresenta cioè da sempre una «costante» nel percorso di sviluppo della nazione. Per di più pare essere in aumento. La realtà storica è che nel 1861 si unificarono Italie diverse perché diverse erano le storie degli Stati preunitari per livelli d’istruzione, strutture sociali e istituzionali, clima, alimentazione. Anche nell’Italia centro-settentrionale esistevano sacche di povertà e di arretratezza. Però la disparità nei redditi, tutto sommato modesta al momento dell’unità, cominciò ad aumentare alla fine dell’Ottocento, quando il Nord-Ovest si aprì all’industrializzazione e il Sud no. La parte settentrionale di questa lunga penisola s’avvicinava all’Europa, quella meridionale meno, anche perché afflitta da una dilagante criminalità.
Sono questioni di cui si discute da un secolo, non serve a molto riassumerle in un articolo. Forse aiuta di più un altro dato che riguarda non l’economia ma la cultura. Un’idea di Italia è esistita molto prima che l’Italia esistesse come entità statale nel concerto delle nazioni. Poeti e scrittori scrivevano d’Italia già nel XIV secolo, ne scrivevano in “volgare” cioè in una lingua che si sarebbe chiamata italiano acquisendo un canone linguistico codificato. Possiamo dire che gli italiani erano “popolo” per unità d’orizzonte e di lingua, molto prima che arrivasse un riconoscimento ufficiale. Solo una minuscola parte degli abitanti però, la più colta, condivideva questi ideali; certo non le masse abbrutite dall’ignoranza più ancora che dalla penuria. I linguisti hanno calcolato quanti fossero gli “italofoni” nel 1861. Tullio De Mauro ha stimato un 2,5% della popolazione; Arrigo Castellani è arrivato al 10%. In ogni caso una drammatica minoranza. Ancora oggi il livello medio di acculturazione non è sempre all’altezza di un mondo che si muove a tale velocità. Nel 1873, il grande storico della letteratura Francesco De Sanctis, in una riflessione sulla scuola in Irpinia scrisse: «La grande piaga dell’Italia è la distanza che separa la classe colta dalla moltitudine, tanto che sembrano due mondi, l’uno fuori dall’altro, l’uno incompreso dall’altro ». Le cose sono parecchio migliorate da allora, ma non abbastanza.
(Corrado Augias, Repubblica del 12 marzo )